
Una chiacchierata tra passato e presente qualche giorno dopo il pranzo dei CSI, che ha furoreggiato via social. Il musicista-scrittore riflette sulla sua ultima opera per Einaudi
Pregate per ea: storia, memoria e lingua per Massimo Zamboni
Di Donato Zoppo
Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti non sono solo i padrini del punk italiano. Sono una coppia artistica che ha cambiato il volto della musica italiana, prima con CCCP poi con CSI. E anche da separati hanno compiuto un percorso parallelo: dai primi anni Duemila sono diventati entrambi scrittori. La loro è una scrittura affine per temi, luoghi, prospettive, ma diversa per tono, tensione, linguaggio. Entrambi hanno molto da dire e ogni libro è l’occasione per entrare nel loro mondo così ricco di passato, memoria, orizzonti. Eppure la provenienza musicale è un vincolo, una gravità che li incatena: un paio di settimane fa con Ferretti ho parlato della nuova edizione Aliberti di Casa d’altri e della sua prefazione ma il tema CSI si è imposto; anche con Massimo e con la sua fresca pubblicazione, durante la chiacchierata è tornato prepotente il richiamo CSI, inevitabile viste le recenti notizie.
Einaudi ha da poco pubblicato il nuovo libro di Zamboni, il dodicesimo: Pregate per ea. È un testo breve ma assai rappresentativo della sua poetica: la scoperta di una lapide nei boschi della Val d’Asta gli ha aperto un mondo, quello di un fatto di sangue occorso nelle sue zone all’indomani dell’Unità d’Italia, l’uccisione di una donna in un arcaico paesino montano e una sequenza di eventi fatti di fughe, scontri, verbali, culture. Un incontro talmente irresistibile da dover essere raccontato. E Massimo lo ha fatto egregiamente, alla sua maniera e con la sua personalità: ricostruendo l’evento, non si è posto come un archivista dal taglio notarile, bensì come un lontano ma appassionato e partecipe osservatore di fatti, personaggi, lingue, su un crinale geografico ma anche cronologico, tra un vecchio mondo preunitario lento e resistente e un nuovo mondo italiano, percepito come invasivo e violento.
L’ho incontrato un paio di giorni dopo un evento che ha generato gioia, commozione e godimento in larghissima parte del pubblico italiano: una foto postata via social da Gianni Maroccolo, poi condivisa e commentata con una generosità straordinaria, scattata poco dopo un pranzo a Cerreto Alpi, da Giovanni, con Gianni, Francesco Magnelli, Ginevra Di Marco e Giorgio Canali. I CSI. Nessuna parola, nessuna presentazione, nessuna anticipazione, ma una foto del genere, che immortala sei musicisti per la prima volta insieme dopo oltre vent’anni, non poteva non generare altissime aspettative di reunion, soprattutto dopo le dichiarazioni del Ferretti. Con Massimo parliamo anche di questo.
Ho letto e apprezzato Pregate per ea tanto da considerarlo come il tuo biglietto da visita definitivo: racchiude temi centrali nella tua poetica come la storia, la memoria, il connubio tra passato e presente calato nei luoghi di sangue e radici, il fare concreto della ricostruzione, il potere della scrittura tra saggio e racconto. Ti ritrovi?
Non ci avevo pensato in questi termini ma in effetti è proprio così perché Pregate per ea contiene tutti i miei temi. Però è un libro strano, non è uscito dalla mia pelle scorticata come L’eco di uno sparo o La trionferà, o come le sperimentazioni sul corpo viaggiante compiute nei libri di viaggio tra Berlino, la Mongolia o il Canale Tartaro, perché è una storia che è capitata ad altri. Al tempo stesso riguarda me perché si svolge nelle terre dei miei avi e perché è nata inciampando in una pietra che mi ha chiamato, così ho avuto un po’ di distacco che ha giovato al libro, nel senso che è un po’ più narrativo – per come si intende comunemente la narrativa – ma con modalità mie, infatti la storia non è protagonista in senso puro perché ci sono dei personaggi e degli accadimenti.
Penso sia un gradino sul quale dovevo salire, infatti ho altri libri in scrittura ma questo mi ha un po’ depistato – chiederò un incontro a Einaudi per fare una conversazione a tema su questo argomento… Ho tanti spunti per altri libri di questo tipo perché le ricerche d’archivio mi consegnano delle storie e ci sono delle idee forti. Per gli altri che avevo in mente pensavo a una saggistica narrata, cioè un pensiero che diventa narrazione, qui invece c’è proprio una storia.
Una storia che coinvolge molti elementi…
Una storia che coinvolge tutto: gli scomparsi, il territorio, il paesaggio, la mia famiglia, la patria, la modalità di scrittura, il rapporto tra scrittura e musica. Da questo punto di vista è molto compiuto. E sono molto contento che sia anche così breve, siamo travolti da questi libri di cinquecento pagine, tanto che mi chiedo sempre: «Ma non si può stringere un po’?»
Però è una brevità apparente, lo è dal punto di vista del numero di pagine ma non nello sviluppo delle azioni, nei personaggi, nei risvolti che portano altrove. Ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente è linguistica: uno dei testimoni dell’omicidio si chiama Paolo ma si firma Pavolo, con la V. Un inconsapevole rimando al latino, scrivi.
È un libro molto denso, come densa è stata la ricerca sulla lingua, sempre così scoppiettante ed etimologica. Per loro il latino, che proveniva da ciò che sentivano leggere in chiesa, era molto più vicino dell’italiano che non parlavano in nessun modo, ancora oggi il loro dialetto è molto ostile per la lingua italiana, quasi incomprensibile… Queste parole hanno una storia lunghissima, e se riesci a farlo cogliere al lettore, allora il tempo del libro si dilunga all’infinito.
A proposito di tempo, la gestazione di Pregate per ea è stata rapida?
La base per la nascita è stata l’incontro con la pietra. Ritrovare una pietra in mezzo al bosco non è facile, così ho voluto subito trascrivere questo impatto su carta per non perdere l’evento. La pietra ha messo in moto un pensiero che ho congelato per quasi dieci anni, non avevo tempo di riprenderla subito perché c’erano altri impegni, altri libri in scrittura, ma anche perchè le cose devono maturare. Due anni fa ho ripreso in mano tutto grazie a un incontro fortunato in Archivio di Stato dove ho ritrovato i faldoni del processo, così la voglia di scrivere si è messa in moto in maniera torrenziale.
Due anni fa non c’era il ritorno dei CCCP?
Certo, infatti ho proprio approfittato del tour dei CCCP, dei viaggi in corriera, dei treni, delle pause, arrivando alla fine della stesura in un biennio, un tempo che per me è stato breve, visto che di solito impiego molto più tempo, penso agli otto anni di L’eco di uno sparo… Comunque per ottenere una scrittura del genere ci vuole molto tempo, le parole devono depositarsi, risalire, risuonare, non è un processo immediato.
Ma l’incontro con la lapide cosa ha fatto scattare in te, dal punto di vista emotivo?
Sono preso da questa terra, per me è mitologica perché me lo hanno insegnato da piccolo che è la terra degli avi. Pensa che ho disboscato una parte di terra qui a casa mia perché volevo avere il Monte Cusna a mia disposizione, era coperto dagli alberi… Questa terra è un riferimento, l’appartenenza prolunga la mia vita, la mia consistenza per secoli: sapere di essere legato a certe storie è un prolungamento. Se arrivo in un paese e mangio una mela che vedo su un albero, sento che è una comunione: allo stesso modo trovare una storia e raccontarla è un avvicinamento consistente, è diventare parte del paesaggio che è istintivamente mio, anche se non abito a una grande distanza da lì. Ma comunque è una distanza, così tutto ciò che mi lascia avvicinare e capire sempre meglio il punto di vista istintuale del luogo, più che storico, è irrinunciabile.
Anche perché i luoghi hanno un elemento sacro, che è qualcosa che precede il religioso.
Ieri stavo leggendo una frase di Pasolini: «Quanto più è sacro, tanto più è animale il mondo». Questo è il mondo che ho raccontato, un mondo animale perché le regole sono dettate in maniera animalesca, che non è un abbassamento di tono, anzi un innalzamento. Sono regole eterne che hanno sempre governato il mondo, le stagioni, l’uomo, gli animali, le piante. Noi tendiamo a sfuggirle perché regolamentiamo il nostro agire, ma questa modalità di vita in montagna è ancora molto presente: basta girare in un bosco di notte. Tutto quello che abbiamo costruito svanisce di fronte al mistero.
Questa riflessione mi fa pensare al diritto naturale, ma soprattutto alla lentezza e alla difficoltà che il diritto civile ha avuto nel penetrare in quelle terre con l’Unità d’Italia, come tu stesso racconti.
Pensa alla vicenda dell’uccisore, Lorenzo Puglia. In quell’ottica, è perfettamente naturale quello che ha fatto: ha ucciso una donna non perché ci fosse chissà quale motivazione ma per uno scatto d’ira, è una legge di natura, per lui logica, perché dominata dalla forza. Il suo pensiero successivo è la presenza dei testimoni, che lo preoccupano non in quanto tali, non perché potrebbero raccontare ciò che hanno visto, ma come persone alle quali dover rendere conto. La loro presenza fa decadere la legge naturale perché si sovrappongono dei codici umani, tribali quasi, il codice di quelle montagne che non è neanche pronunciato, è tacito perché si sa, è assimilato anche se non se ne ricorda più la fonte. Solo successivamente da quelli della legge italiana, che come scrivo stringe le montagne come un cappio, ricevendo in cambio una ostinata riottosità.
Ostilità che, stando anche a tanti tuoi racconti, persiste in parte anche tuttora…
Un’ostilità un tempo diffusa, ora sotterranea, di cui ci sono le ultime percentuali, rispetto a tutte le leggi, leggine e regolucce dello Stato. Chi vive in montagna le sente come un’invasione arbitraria perché una cosa è amministrare un territorio, altro è viverlo e condurlo, gestirlo con le mani secondo codici antichissimi. Infatti il legiferare da parte di persone sedute a un tavolo può essere percepito come un’ingiustizia.
Il clima arcaico che rievochi nel libro ha una persistenza nell’oggi?
Scrivo chiaramente che le radici hanno bisogno di oscurità per prosperare, e questo vale anche nei luoghi più elevati dell’Appennino dove vivo io. A mio avviso c’è anche una parte di animismo che non viene mai espressa, e penso all’uomo che parla con le sue piante, o con una talpa, o che ingiuria contro un attrezzo per un accadimento. È la sopravvivenza di un rapporto istintivo con le cose, le bestie, il creato. Al tempo stesso c’è stato un secolo e mezzo di dominazione statale e le regole sono arrivate e osservate, inoltre ricordo che questi sono stati anche luoghi partigiani, oggi sono frequentati perché luoghi di cultura e turismo, nè bisogna dimenticare che anche il cattolicesimo ha modellato ulteriormente tutto. Dunque c’è un insieme di cose ma anche una perplessità rispetto alla gestione burocratica del territorio, diventa una forma di ostilità silenziosa, non si esprime con la violenza o con le parole, è una sorta di fastidio.
Tu lo provi?
A essere sincero, dopo trent’anni di vita in montagna sì, lo provo anche io: ci vuole un regolamento antisismico per costruire una legnaia, tanto per fare un esempio, o un piano regolatore se fai un pollaio di tre metri… Chi vive in montagna non può che sentirlo come un sopruso.
Secondo le antiche leggi della montagna servono venticinque anni di presenza ininterrotta per essere accettati, tu hai superato questo tempo…
Sì, ad oggi sono trentuno anni di vita continua, preceduti da un po’ di anni di andate e ritorni,
quindi sì, sono diventato un montanaro saccente! [ride, Ndr]
Hai dimenticato la provenienza padana della pianura allora…
Amo profondamente la pianura anche se mi fa infuriare, e la testimonianza è in La trionferà e L’eco di uno sparo, che sono libri di pianura. Quando si parla di Emilia si pensa sempre a “quella” Emilia, ma c’è anche questa. E comunque venticinque anni sono stati un tempo giusto perché prima il tempo si perdeva nell’esplorare, nel curiosare, nel voler capire e nel voler fare come fanno gli altri, poi capisci che non c’è niente da visitare, niente da vedere se non la porzione di terra che ti è stata data in custodia e dalla quale tu sei custodito. Non c’è curiosità, tantissime persone del paese non sono mai venute a casa mia, d’altronde cosa dovrebbero venire a vedere? Una bella casa sicuramente, ma le piante sono piante così come tutto il resto, insomma non è di loro interesse. È difficile alzare il capo dal lavoro, qui. E questo sconfessa tutta una letteratura sul cielo, le stelle, il panorama, la conoscenza dell’altro.
Questo si collega alla staticità dei protagonisti del libro, che si spostano a Villa Minozzo dal magistrato perché minacciati di essere presi con la forza, oppure fuggono verso Parma perché costretti in quanto colpevoli, come il Gambaccia. Il confronto di quest’ultimo con la città, così vicina ma così distante, è un passaggio importante.
È una fuga verso la città che si ferma lì perché poi i viveri finiscono e gli uomini devono vivere come uomini e non come animali braccati. Lorenzo si ferma a Parma dove vede che il cielo si allarga, il torrente si ingrandisce e diventa fiume, gli alberi sono diversi, il dialetto ha le O e le A larghe, il suono della lingua è diverso da quello della montagna che è chiuso e sospettoso perché proveniente da luoghi invasi dalla natura, da forze estranee. La pianura è l’assestamento, la grande città, la popolazione, le donne vestite bene, i cavalli con i finimenti e non più le bestie allo stato brado, le guardie, un mondo di marziani per chi proviene dal crinale.
Parlavamo con Giovanni di Casa d’altri, del paese visto da Silvio D’Arzo in questa descrizione letteraria, un paese inquietante perché immobile. È così anche per Monteorsaro di Pregate per ea?
È la staticità della vita che va avanti, che procede secondo un ritmo che la rende uguale a sé stessa, la nascita, la morte, le bestie da portare al pascolo, tagliare la legna, potare le siepi. In questa ripetizione continua c’è tutta la vita della montagna, ma mi riesce difficile chiamarla statica visto che erano persone che uscivano alle quattro del mattino e rincasavano all’imbrunire per svolgere tutti i lavori faticosi della giornata: è molto più statica la nostra vita da seduti al pc… Buona parte di loro però non aveva mai visto il mare, che pure è al di là del crinale: altri si muovevano solo per motivi commerciali, tipo andare in Garfagnana a prendere le castagne o andare a lavorare le vigne in Toscana. Il turismo, il pensiero, la curiosità sono invenzioni molto moderne.
Questa lentezza che crea un apparente immobilità si evince anche nei nomi, che da tradizione si ripetono, tanto che per distinguere le persone si ricorre spesso ai soprannomi, come Gambaccia e Baffarel.
La tradizione prevedeva che il primo figlio maschio prendesse il nome del nonno paterno e così via nelle generazioni. Può sembrare staticità o poca fantasia, ma in realtà è un cerchio che rotola giù dalla montagna e non si ferma mai. L’unico modo per distinguersi era effettivamente lo “stranum”, lo stranome, ossia tutto ciò che va al di là del nome, spesso una caratteristica fisica che diventava carta d’identità e segno distintivo; a volte si usavano anche i nomi propri, ad esempio Gino soprannominato Afro. La cosa bella è che si trasmette anche lo stranome: la figlia di Gambaccia non ha un suo nome ma è la figlia di Gambaccia…
La vittima è una donna ma leggere quella vicenda con l’ottica contemporanea del femminicidio sarebbe un anacronismo, non trovi?
Non va accostata alle dinamiche attuali dove c’è una ricerca di emancipazione, spesso soffocata. Che l’uccisa fosse una donna era un caso, avrebbe potuto essere anche un uomo la vittima del litigio. Le donne sono molto presenti perché è stata uccisa una di loro, e nei paesi questo può essere fonte di dolore ma anche fonte di gioia nascosta – non dimentichiamo che le radici prosperano nell’oscurità. Però non è questa l’ottica con cui leggere il libro, anche quella violenza era molto presente: si poteva essere uccisi perché si spostava una pietra confinaria o perché si rubava legna o le pecore di un rivale. C’erano risse, lotte, bastonate, schioppettate, modalità aggressive in codici che prevedevano la violenza per regolare i conti. Nel 1400 il Codice di Minozzo prevedeva che non era perseguibile un marito che picchiava la moglie fino a provocarle delle menomazioni: ciò non avrebbe fatto altro che complicare la situazione familiare. Un’assoluzione che per noi è di una ferocia totale, ma la vita lì è stata regolata per secoli in questo modo.
Un altro filo conduttore è la lingua. Quando vengono trascritte nei verbali le dichiarazioni dei testimoni ci sono due mondi: una lingua arcaica e d’uso, resistente al cambiamento, e un italiano “ufficiale” rigido e giuridico.
La legge italiana tramite avvocati, pretori e cancellieri tenta di addomesticare una lingua animalesca, quella del crinale, un dialetto diverso anche da quello delle borgate confinanti. Nessuno dei protagonisti avrebbe mai usato un aggettivo, un congiuntivo o un avverbio, o costruzioni verbali complesse e auliche come quelle trascritte nei verbali. La lingua del crinale era molto immediata: la parola corrisponde all’oggetto, null’altro. Non c’è psicologia, non c’è sotterfugio, non c’è ricamo. È una lingua svelta perché non c’è tempo di fare altro, l’oggetto è tale e merita di essere presentato senza tanti giri. Quello dell’avvocato è un tentativo goffo, quel cavillare alle nostre orecchie sembra persino cantilenante, musicale.
Nei ringraziamenti, tra i nomi di persone e istituzioni che hanno dato solidità e materia allo scritto, ho notato Giovanni Lindo Ferretti. In che modo lo hai coinvolto?
Gli avevo fatto leggere la prima stesura, in una fase molto arretrata, perché volevo essere sicuro che una serie di combinazioni che avevo messo in atto nel libro fossero fondate, plausibili agli occhi di chi vive in quei luoghi, che abita da secoli sul crinale. La Val d’Asta non è vicina ai luoghi di Giovanni ma ne condivide le modalità, è più defilata ma è un luogo di transito come la Statale 63 lungo la quale abita lui, che è sempre stata una strada di grande percorrenza anche dai pellegrini. Avevo bisogno di un colpo d’occhio da parte di un montanaro sui montanari da me descritti, e il responso è stato molto positivo. Un buon incentivo a proseguire.
Tu e Giovanni avete debuttato insieme nella scrittura con In Mongolia in retromarcia, poi dopo la fine dei CSI e la separazione hai esordito per primo con Emilia Parabolica. Il suo Reduce è arrivato quattro anni dopo. È sorprendente che due padrini del punk italiano, una coppia che ha cambiato il volto della nostra musica, siano anche scrittori, e con tematiche e geografie vicine. Lo stile però è diverso…
Siamo un po’ una dannazione l’uno per l’altro [ride, Ndr], detto in senso benevolo.
Secondo me abbiamo un orizzonte mentale molto simile perché ci siamo costituiti insieme nella fase della formazione, ma anche perché viviamo tensioni non così dissimili. La modalità di scrittura però è diversa: quella di Giovanni è più spezzettata, a volte anche ad effetto, la mia è più riflessiva, si basa sulla storia, impiego molto tempo e ne dedico altrettanto alle ricerche, posso astrarre le storie da me e non necessariamente devono parlare di me. Giovanni è più concentrato su ciò che lo riguarda direttamente, ma ci sono affinità e divergenze in ogni cosa, anche in questo caso. E comunque c’è sempre un tenersi d’occhio a distanza.
Distanza che non c’è stata qualche giorno fa, come ha testimoniato una foto che ha fatto scalpore: i CSI dopo pranzo, al Cerreto, tutti insieme. Su una pietra sei inciampato e hai scritto una storia, intorno alla pietra CSI che succederà?
C’è stata questa foto sciagurata uscita l’altro giorno, nonostante le imprecazioni perché mai avrei voluto uscire in quel modo [ride, Ndr] ma a volte scappano i cavalli dalla stalla… Dopo aver visto la foto avevo voglia di alzarmi dall’inciampo e proseguire per la mia strada!
Ma a parte questo, il primo effetto che mi ha fatto vederci tutti insieme nella stanza è stato chiedere: Ma davvero siamo così pochi? Eravamo in sei, e solitamente i CSI sono sempre stati attorniati da una moltitudine di amici, colleghi, tecnici, organizzatori. Non ci siamo mai visti in sei se non in sala di registrazione, ma anche lì c’era un viavai di persone. Mi ha fatto molto piacere vederci, penso che forse stavolta in così pochi ce la facciamo a governarci, visto che le presenze esterne sono sempre un’infiltrazione che porta appoggi ma anche solidarietà oblique.

La reunion dei CSI (28/10/2025)
Inevitabile chiederti cosa rappresenti quella foto, oltre la dimensione della convivialità.
È stato un incontro piacevole per i motivi che ti ho detto, avrei voluto esprimere questo piacere in tutt’altro modo, quella foto non significa nulla perché dal ritrovarsi piacevolmente a pranzo al montare sul palco c’è un tempo assolutamente infinito, e non è neanche detto che si possa attuare. Ci siamo dati una piccola disponibilità, si vedrà.
Può essere un tempo lungo di gestazione come quello di Pregate per ea?
Siamo adulti, e quando si è adulti non si ha più una grande disponibilità di tempo per motivi familiari o lavorativi, ognuno di noi è imbrigliato in mille limiti, anche se piacevoli: Gianni con la reunion dei Litfiba, io con un paio di tour, Giovanni con il suo spettacolo, Ginevra, Francesco e Giorgio hanno mille concerti. Non è facile trovare uno spazio, la voglia è quella di lasciare andare le cose e vedere cosa capita.
Stavo pensando al sacro e l’animale che hai citato prima, e mi è venuto in mente che Ginevra mi disse: «Con Giovanni sul palco ho avuto un’intesa animale». È una dimensione non mediata dal linguaggio verbale che caratterizza i gruppi e in particolare i CSI, collettivo di personalità tanto diverse…
Questa parte animale si materializza principalmente sul palco, non negli incontri in cui siamo persone. Sul palco si crea qualcosa che va al di là di noi. È una creatura musicale che emerge da noi e che fagocita un po’ tutto, è strano. È un carattere rituale che ci riguarda tutti, non solo l’intensità di Giovanni, è una cosa che ci comprende tutti, difficile da spiegare. Storicamente l’ingresso di Ginevra ha aumentato ancora di più questa possibilità, ma va al di là delle chitarre, del basso, prende immediatamente la forma del rito, dunque del sacro e dell’animale.
Mi dicesti che nella musica si scioglievano le conflittualità di un gruppo del genere…
Beh, siamo rimasti uniti non certo perché ci fossimo simpatici l’uno con l’altro, perché ci raccontiamo belle storie o facciamo dei viaggi assieme… Non c’è niente che ci leghi se non qualcosa di potente che va al di là di noi: è la completezza della nostra musica. Dal punto di vista individuale sicuramente ci vogliamo bene e c’è ascolto degli uni verso gli altri, ma non c’è motivo di grande interesse se non per quello che esce in comune, che è sempre sorprendente perché è più della somma delle singole parti.
Quella foto ha generato godimento in migliaia di persone, lo ha dimostrato l’elevato tasso di commenti e condivisioni via social che confermano – ma non c’era bisogno di ricordarlo – il grande affetto verso di voi. Queste aspettative ti lasciano indifferente o le tieni in considerazione?
Indifferenza mai. Rispetto alla foto, la mia reazione è stata di arrabbiatura: mai avrei voluto vedere una foto del genere esposta in maniera così sventata [ride, Ndr]. Le foto comunicano qualcosa e quella non vuol dire che ci siamo, ci saremo e faremo concerti: vuol dire che ci siamo trovati a pranzo, che abbiamo voglia di fare qualcosa insieme ma non che ci vedrete tra tre mesi sul palco. Ci sono dei codici che viaggiano in modalità incontrollata e che invece vanno gestiti, non in maniera dispotica ma con il controllo, altrimenti si entra in una bolla di inconsistenza: non ci si può arrendere al flusso delle informazioni, una foto o un post si depositano nelle aspettative delle persone. E queste aspettative vanno condotte, perché un’aspettativa sbagliata crea un pubblico sbagliato, o delle illusioni, o degli errori. Serve attenzione e lo abbiamo anche cantato: «Occorre essere attenti per essere padroni di sé stessi».
Forse è solo con i libri che si riesce a essere attenti, a padroneggiare con attenzione? La tua scrittura rivela questa sorveglianza.
Non sapendo scrivere la musica, mi devo confrontare con una creatura liquida e inafferrabile ed è sempre una lotta. Con la parola scritta è diverso: sta ferma lì sul foglio e non si muove finché non lo dico io. Non è indice di dispotismo ma di verticalità: quella parola la guardo, la studio, la seziono infinite volte perché deve essere esattamente quella, non ci sono possibilità di sinonimi. La prima stesura è sempre di getto, poi la fermo e la tengo lì, la torturo fino alla fine… Tengo molto a questo controllo, ho il terrore di quei romanzi fluviali – a meno che non siano dei capolavori – su cui tutti si buttano e diventano anche bestseller, vedi che li leggono in treno. Infatti mi chiedo: Ma perché dedicano il tempo della lettura a qualcuno che non è stato capace di dominare il proprio istinto?
Quello che mi descrivi sa molto di artigianale, come una scultura dalla quale togli l’eccesso e ciò che resta è proprio quello che deve esserci. Dopo oltre vent’anni di scrittura fitta e densa, tangibile, ti senti ancora “fatto di aria”, come dici spesso?
Mentalmente mi sento molto solido, poche cose possono scalfirmi fino in fondo. Sono molto solido anche nel mio lavoro contadino, si vede dalle mani, le uso sia nello scrivere che in campagna. Però è vero che sono fatto di aria, un soffio di vento mi spinge dove vuole: ho cinque o sei libri in scrittura, tantissime canzoni pronte, nel computer la cartella dei lavori in corso è infinita. Mi basta una frase per farmi pensare che quel progetto è finito, ma capita che passino dodici anni per riprenderlo e portarlo a termine davvero. Mi trovo al centro di tanti richiami, una infinità di storie musicali e narrative che meriterebbero attenzione e non può bastare una vita: la capacità di distrazione è totale, ma anche quella di concentrarsi al momento opportuno lo è.
I CSI ora sono elemento di distrazione o concentrazione?
Al momento di distrazione, perché ho un’idea chiara di quello che devo fare e devo scrivere. Quando dico “devo” intendo dire che ci sono cose che il mio corpo chiede espressamente di raccontare ma anche cose che devo lasciare perché penso possano essere importanti per i miei famigliari o per le persone che mi conoscono. Per quanto riguarda le canzoni, ci sono invece canzoni che posso o non posso fare, ma altre che devo fare: si impongono e sento di doverle registrare e mandare fuori a dispetto del mercato, del commercio, di Spotify eccetera. Quelli sono incidenti di percorso, l’importante è che la canzone esista.
Tra tutte le storie che ti portano altrove, ce n’è qualcuna che si sta imponendo alla tua attenzione di scrittore ultimamente?
Ho in mente un libro enciclopedico che sto cercando di riportare a una dimensione umana, che riguarda la mia famiglia. La conosco dal Seicento in avanti, non perché fossero dei nobili ma perché erano pastori, dunque abbastanza facili da localizzare, ma non mi interessa la storia in quanto tale, bensì come strumento per leggere il mondo che cambia. Ho come riferimento Archivi del Nord di Marguerite Yourcenar. Mi stimola molto la genealogia, l’idea che noi abbiamo in pratica affidato a uno spermatozoo il compito di raccontarci, mi colpisce questa trasmissione per via maschile e l’allontanamento del femminile in linea genealogica. A un certo punto le donne diventano “donne d’altri”, non proseguono il proprio cognome, invece il lontano Giovanni Battista Zamboni che mi precede dal 1600 me lo porto ancora addosso. È una catena di pensieri che mi chiedo se potrà arrendersi tra la saggistica e la narrativa.
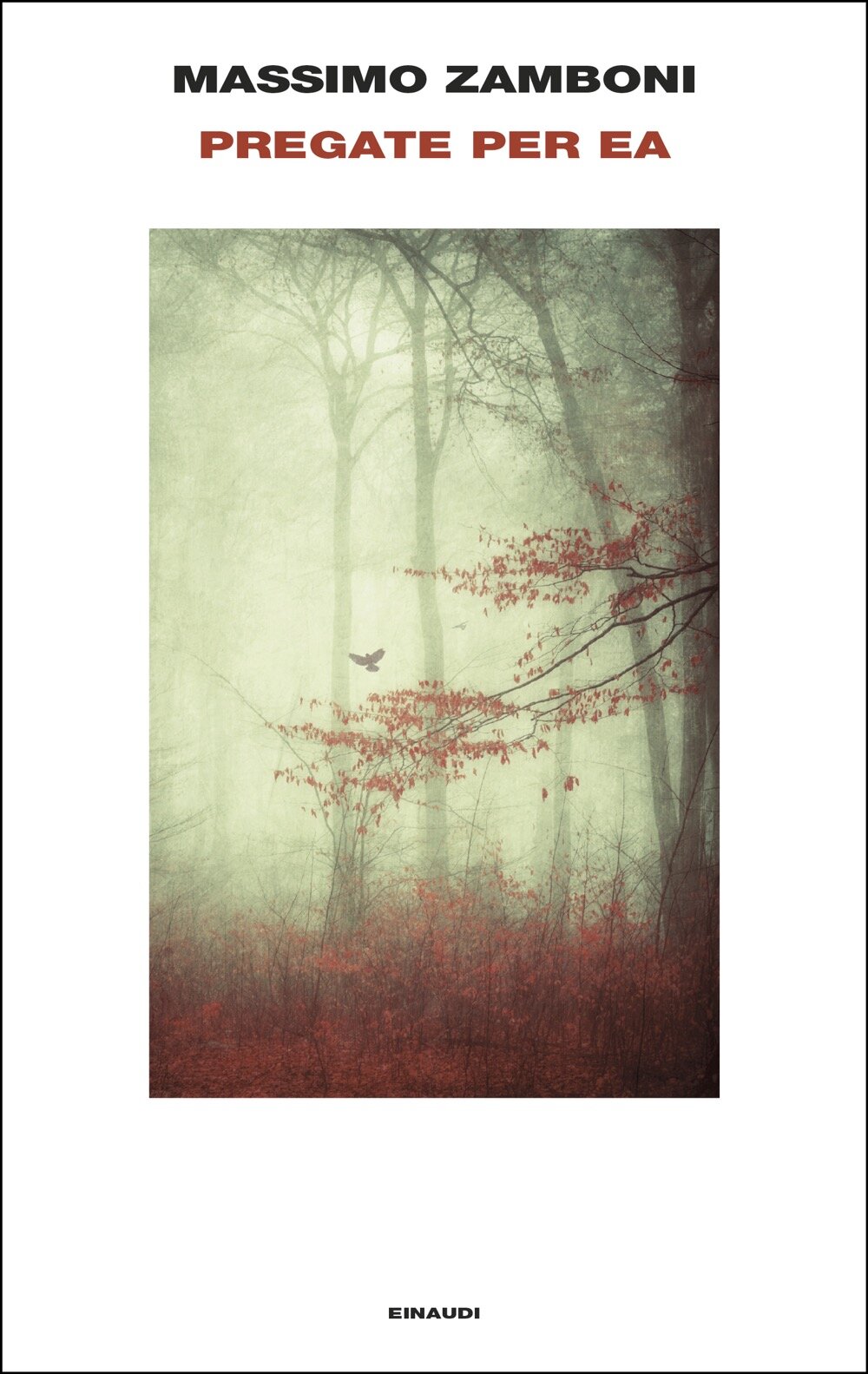

Massimo Zamboni e Donato Zoppo